Gli imperi non crollano a causa di nemici esterni. Non attraverso la conquista. Non attraverso la rivoluzione. Si sgretolano dall’interno, mentre la fiducia nella loro moneta decade silenziosamente – la lenta morte della loro valuta. Sarà il prossimo l’impero americano?
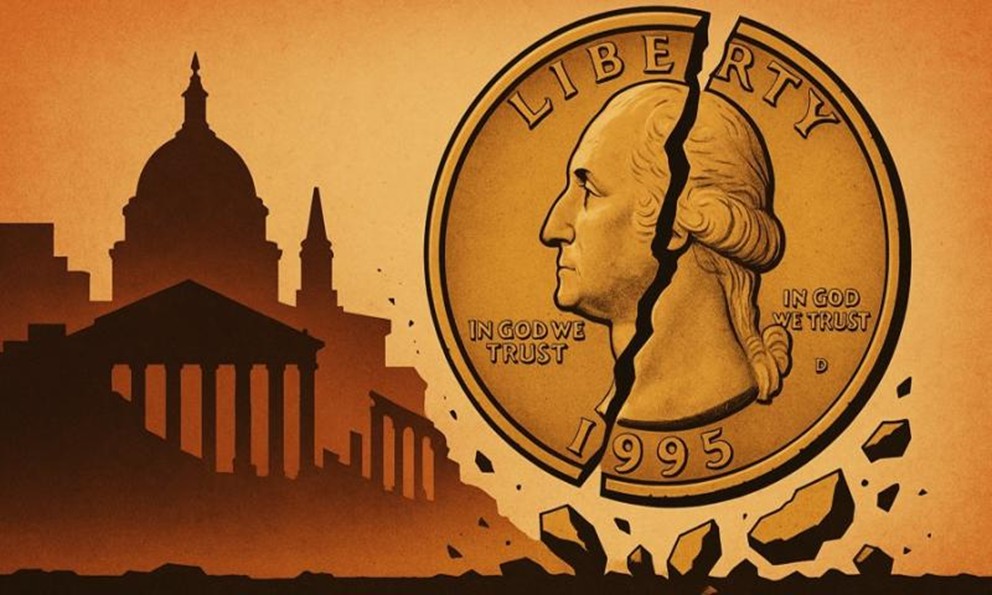
Felix Abt, forumgeopolitica.com, 9 novembre 2025 — Traduzione a cura di Old Hunter
Dire che questa sia l’unica causa sarebbe una semplificazione. Gli imperi raramente crollano per una sola ragione. Corruzione politica, eccessiva decadenza sociale, guerre straniere e disastri naturali contribuiscono tutti alla loro causa. Eppure, al di sotto di ciascuna di queste crisi si cela una costante: l’eccesso di potere fiscale e la svalutazione monetaria, ovvero l’erosione della fiducia finanziaria che tiene unita la civiltà.
Quando la valuta di un impero fallisce, si tratta di più di un evento economico. È una crisi di fede: una perdita di fiducia nelle promesse dello Stato, nell’idea stessa di valore. Il denaro, dopotutto, è fiducia resa tangibile: la convinzione condivisa che un simbolo rappresenti un valore reale. Una volta che questa convinzione si spezza, nessun esercito o burocrazia può ripristinarla.
Come ha scritto lo storico Niall Ferguson in The Ascent of Money (2008):
“Il denaro è fiducia inscritta. Quando quella fiducia muore, muore il denaro, e quando muore il denaro, muoiono con lui gli imperi.”
Roma: il primo grande esempio di collasso monetario
Il denario romano era un tempo tra le valute più affidabili della storia: una moneta d’argento quasi puro, introdotta intorno al 211 a.C. Per oltre due secoli, ha sostenuto il commercio, la tassazione e la paga delle legioni romane.
Ma mantenere un simile impero era estremamente costoso. I confini si estendevano su tre continenti, l’esercito contava centinaia di migliaia di uomini e le spese amministrative crescevano inesorabilmente.
Quando le entrate fiscali non riuscirono più a tenere il passo, gli imperatori si rivolsero alla zecca. Sotto Nerone (54–68 d.C.), il contenuto d’argento del denario scese da quasi il 100% a circa il 90% – un cambiamento apparentemente di poco conto che contribuì a finanziare guerre e progetti di costruzione monumentali. Sotto il regno di Caracalla (211–217 d.C.), il contenuto d’argento era sceso a circa il 50%. Sotto Gallieno (253–268 d.C.), conteneva meno del 5% d’argento – poco più di una sottile patina su metallo vile.
(Fonti: Michael Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire; Peter Temin, The Roman Market Economy, 2013. )
I prezzi salirono alle stelle. Nel 300 d.C., ciò che un tempo costava un denaro poteva arrivare a costarne cinquanta. I soldati pretendevano il pagamento in oro o tramite baratto; i contadini rifiutavano le monete svalutate. L’economia si fratturò.
Ciò non fu causato da un’invasione, quella arrivò in seguito. Come notò Joseph Tainter in The Collapse of Complex Societies (1988), la vera rovina di Roma fu la sovraestensione economica: l’incapacità di sostenere la complessità che aveva costruito. La svalutazione della moneta fu sia un sintomo che un acceleratore. Quando la moneta di Roma morì, morì anche la sua capacità di pagare eserciti, costruire strade e mantenere la lealtà. L’impero non crollò semplicemente: si disgregò dall’interno.
Spagna: ricchezza senza produzione
Mille anni dopo, la Spagna ripeté lo stesso schema, questa volta attraverso un eccesso di argento anziché una sua carenza.
La scoperta di Potosí, nell’odierna Bolivia, nel 1545 scatenò un’ondata di lingotti d’argento provenienti dal Nuovo Mondo, quasi la metà delle riserve mondiali d’argento per oltre un secolo. All’inizio, sembrò una ricchezza illimitata. Ma come documentò l’economista Earl J. Hamilton in American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501–1650 (1934), questa abbondanza si rivelò un’illusione.
L’inondazione dell’Europa di argento innescò un’inflazione massiccia. I prezzi in Spagna aumentarono di circa sei volte tra il 1500 e il 1600. Più argento veniva estratto dall’impero, meno valeva. La corona spese generosamente per le guerre – contro gli Ottomani, gli Olandesi e l’Inghilterra – trascurando l’industria nazionale. La Spagna importava navi, armi e tessuti dal nord Europa e li pagava in argento.
Verso la fine del XVI secolo, Filippo II era sommerso dai debiti – con un debito di oltre 36 milioni di ducati – e dichiarò bancarotta quattro volte tra il 1557 e il 1596. Ogni inadempienza distrusse il credito della Spagna e ne determinò un ulteriore deprezzamento. Come scrisse lo storico J.H. Elliott in Imperial Spain, 1469–1716 (1963):
“Il paradosso del potere spagnolo era che la sua ricchezza ne minava le fondamenta”.
L’impero spagnolo non scomparve dall’oggi al domani. Ma nel 1700 era ormai vuoto: ricco di storia, povero di produttività, gravato dall’inflazione e privo della fiducia nella sua moneta.
Gran Bretagna: l’impero costruito sul credito
Al suo apice, l’Impero britannico dominava un quarto del territorio e della popolazione mondiale. La sua forza non si basava sui tesori, ma sulla credibilità. La sterlina, sostenuta dall’oro, era la valuta di riserva globale.
Come ha osservato l’economista Barry Eichengreen in Globalizing Capital (1996):
“Il gold standard era il collante che teneva assieme il sistema globale guidato dalla Gran Bretagna”.
Quel collante iniziò a indebolirsi nel XX secolo. La Prima Guerra Mondiale costrinse la Gran Bretagna ad abbandonare la convertibilità in oro e a stampare moneta per finanziare il conflitto. Il debito pubblico salì da 650 milioni di sterline nel 1914 a oltre 7 miliardi di sterline nel 1919, decuplicando in soli cinque anni.
Quando Winston Churchill, in qualità di Cancelliere dello Scacchiere, ripristinò il gold standard alla parità prebellica nel 1925, la sterlina sopravvalutata strangolò le esportazioni e aggravò la disoccupazione. La Gran Bretagna abbandonò nuovamente l’oro nel 1931, questa volta definitivamente.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il rapporto debito/PIL della Gran Bretagna superò il 270%. Con gli accordi di Bretton Woods (1944), il dollaro statunitense sostituì la sterlina come moneta di riferimento del sistema finanziario globale. La sterlina fu svalutata nel 1949 e di nuovo nel 1967, erodendo ulteriormente la fiducia.
Come scrisse lo storico Kenneth O. Morgan in The People’s Peace: British History 1945–1990 (1992):
“La Gran Bretagna perse un impero non a causa di una sconfitta in battaglia, ma a causa dell’esaurirsi del suo credito”.
Il ritiro dell’impero – dall’India nel 1947 a Suez nel 1956 – rifletteva il suo declino monetario. Quando la valuta perse il suo punto di riferimento, anche l’influenza dell’impero svanì presto.

L’instabilità monetaria negli imperi russi
Volgendo lo sguardo a Oriente, il crollo degli imperi russi fu strettamente legato all’instabilità monetaria e fiscale. Nel tardo Impero russo, deficit cronici, spese belliche e pressioni inflazionistiche minarono la fiducia del pubblico e acuirono le tensioni sociali, contribuendo a scatenare la rivoluzione del 1917 e l’abdicazione dello zar Nicola II.
Anche l’Unione Sovietica dovette affrontare gravi problemi valutari e fiscali: l’iperinflazione successiva alla Guerra Civile rese necessaria la Nuova Politica Economica (NEP), mentre decenni di pianificazione centralizzata, tassi di cambio artificiali e squilibri di bilancio crearono una cronica debolezza economica. Negli anni ’80, l’aumento dell’inflazione, una moneta non convertibile e la cattiva gestione fiscale intensificarono le crisi politiche e sociali, accelerando la dissoluzione dell’URSS nel 1991.
In entrambi i casi, l’instabilità economica non ha agito in modo isolato, ma ha amplificato le fratture politiche e sociali esistenti, secondo uno schema storico familiare: le crisi valutarie spesso precedono la caduta degli imperi.
La Cina è un’eccezione?
Sebbene la Cina sia una delle civiltà più antiche del mondo e abbia acquisito nuova importanza negli ultimi trent’anni dopo due secoli di turbolenze, ha ripetutamente affrontato sfide simili nel corso della storia. Il destino delle dinastie cinesi era strettamente legato al loro controllo del denaro, del credito e delle finanze statali.
Sotto la dinastia Tang, le cause immediate della rivolta di An Lushan furono di natura politica e militare – ambizioni di potere, intrighi e tensioni etniche – ma i problemi monetari e il parziale collasso della valuta crearono un ambiente favorevole alla rivolta, aggravandone le conseguenze fiscali e sociali una volta scoppiata. La rivolta durò quasi otto anni (755-763) e causò circa 13-36 milioni di vittime.
La dinastia Song, che introdusse la prima moneta cartacea al mondo all’inizio dell’XI secolo, affrontò crisi esistenziali dovute all’inflazione e alla perdita di fiducia nelle banconote emesse in eccesso.
Sotto lo Yuan, i Mongoli ripeterono lo stesso errore, inondando l’economia con carta moneta non coperta, il che portò all’iperinflazione e al collasso dello Stato.
I Ming si rivolsero all’argento, ma quando nel XVII secolo gli afflussi globali si esaurirono, l’improvvisa carenza soffocò le entrate fiscali e contribuì in modo significativo alla caduta della dinastia.
Persino i Qing, a lungo rimasti stabili sotto un sistema bimetallico, affrontarono enormi pressioni nel XIX secolo, quando l’argento affluì verso l’estero per pagare l’oppio e le cosiddette “indennità” imposte dalle potenze coloniali occidentali. Questo deflusso scosse le fondamenta finanziarie dell’impero, indebolì il controllo statale su tasse e monetazione e contribuì in modo decisivo all’instabilità politica. La crisi rivelò la vulnerabilità anche di sistemi monetari a lungo stabili e illustrò lo stretto legame tra stabilità economica e forza politica.
In Asia, la storia non è un archivio remoto, ma uno standard di vita in base al quale si misurano presente e futuro. Una lezione fondamentale del Regno di Mezzo attraversa i secoli: quando il centro politico si indebolisce, segue il caos: guerra civile, crollo, milioni di morti. Questa consapevolezza storica plasma ancora oggi le politiche della Cina. Le riserve auree vengono accumulate, la dipendenza dal dollaro gradualmente ridotta, i rischi ampiamente diversificati. Dietro tutto questo non c’è un pragmatismo a breve termine, ma un istinto profondo: stabilità significa sopravvivenza. La fiducia nella propria moneta, la coesione politica e la lungimiranza strategica derivano tutte dall’esperienza, non dalla dimenticanza.
Se questo sia sufficiente per sfuggire al ciclo della storia resta incerto. Ma una cosa è chiara: le lezioni degli imperi passati non sono svanite in Cina. Sono state interiorizzate e messe in pratica.
Da Roma all’America: il modello economico del declino
Roma, Spagna, Gran Bretagna: secoli, tecnologie e nemici diversi, eppure la sequenza è sorprendentemente coerente:
- Espansione oltre i limiti sostenibili.
- Deficit fiscali per mantenere tale espansione.
- Svalutazione della valuta o sovraemissione per coprire i deficit.
- Inflazione, seguita da disordini sociali.
- Perdita di fiducia, sia a livello nazionale che internazionale.
- Collasso o contrazione forzata.
Non si tratta di una coincidenza, ma di logica economica. Come osserva Ray Dalio in Principles for Dealing with the Changing World Order (2021) – con un’inequivocabile allusione al più grande impero odierno, ma già in declino – gli Stati Uniti:
“La fase di declino di un impero è sempre accompagnata dalla stampa di moneta, dall’aumento del debito, dai conflitti interni e dalla perdita dello status di valuta di riserva”.
Le sconfitte militari e le crisi politiche seguono il declino monetario, non lo precedono. Gli eserciti perdono le guerre quando non possono essere pagati. I cittadini perdono fiducia quando i loro risparmi svaniscono. I governi perdono legittimità quando le loro promesse valgono meno della carta su cui sono stampate.
Perché il crollo della valuta è ciò che conta di più
Gli imperi possono sopravvivere a disastri militari, catastrofi naturali e persino guerre civili, purché il loro denaro conservi la fiducia.
Ma quando il denaro fallisce, corrode tutto ciò che è stato costruito su di esso: il sistema fiscale, l’esercito, l’economia e lo stesso contratto sociale.
Il crollo monetario non segna solo la fine dell’impero, ma rivela anche quanto il declino si sia già esteso. L’inflazione di Roma ne erose la lealtà. Il boom dell’argento spagnolo ne svuotò l’industria. Il debito della Gran Bretagna ne privò la sovranità. In ogni caso, il denaro fallì per primo, e tutto il resto seguì.
Come avvertì l’economista Ludwig von Mises in L’azione umana (1949):
“La solidità del denaro è il fondamento della civiltà stessa”.
La storia parla chiaro. Gli imperi possono crollare per molte ragioni, ma la loro fine inizia sempre quando crolla la fiducia nel loro denaro. Oggi, gli Stati Uniti si trovano ad affrontare un debito senza precedenti, la loro valuta è sottoposta a un’enorme pressione e i segnali di un’imminente perdita di fiducia sono inequivocabili.
Quando le fondamenta vacillano, tutte le strutture sono a rischio: l’economia, l’esercito, la società – nulla viene risparmiato. La durata dell’impero americano potrebbe quindi essere molto più breve di quella dei suoi illustri predecessori, e il suo declino potrebbe arrivare più velocemente di quanto molti immaginino.
Fonti:
Brandt, L., e Thomas G. Rawski. La grande trasformazione della Cina: studi selezionati di storia economica e sociale. Cambridge University Press, 2008. – Esplora le politiche fiscali, le strutture economiche e le pratiche monetarie in Cina nel corso delle diverse dinastie.
Dalio, R. Principi per affrontare il cambiamento dell’ordine mondiale. Simon & Schuster, 2021. – Esamina i cicli storici dell’ascesa e del declino degli imperi e il ruolo della stabilità finanziaria nel potere statale.
Eichengreen, B. Globalizzazione del capitale. Storia del sistema monetario internazionale. Princeton University Press, 1996. – Offre un contesto sui flussi monetari internazionali e sulle crisi valutarie che colpiscono imperi e stati.
Elliott, JH Spagna imperiale, 1469–1716. Penguin, 1963. – Esamina le politiche fiscali e monetarie della Spagna durante la Rivoluzione dei prezzi; fornisce una panoramica comparativa della storia economica cinese.
Ebrey, PB Storia illustrata della Cina a Cambridge. Cambridge University Press, 2010. – Panoramica completa della storia cinese, compresi gli aspetti economici e fiscali delle varie dinastie.
Ferguson, N. L’ascesa del denaro. Penguin, 2008. Esamina la storia finanziaria globale, comprese le innovazioni cinesi nell’amministrazione monetaria e fiscale.
Fairbank, JK e Merle Goldman. Cina: una nuova storia. Belknap Press, 2006. – Testo di riferimento standard sulla storia cinese; descrive in dettaglio le politiche fiscali, le crisi monetarie e la stabilità dinastica.
Gregory, PR e Robert C. Stuart. Performance e struttura economica russa e sovietica. 2a edizione, Addison-Wesley, 1999. – Analisi dettagliata dei sistemi fiscali e monetari russo e sovietico, compresi inflazione, deficit e crisi economiche.
Hamilton, EJ. Il tesoro americano e la rivoluzione dei prezzi in Spagna, 1501-1650. Harvard University Press, 1934. – Studio classico sugli afflussi di argento e l’inflazione; fornisce un contesto per la storia monetaria delle dinastie Ming e Qing.
Hsu, ICY L’ascesa della Cina moderna. Oxford University Press, 2000. – Esamina le crisi fiscali tardo imperiali, i flussi d’argento e le sfide monetarie che contribuirono al declino delle dinastie Ming e Qing.
Kotkin, S. Armageddon evitato: il crollo sovietico, 1970-2000. Oxford University Press, 2008. – Si concentra sulle crisi fiscali e valutarie della tarda epoca sovietica e sul loro ruolo nel collasso politico.
Liu, K., e Richard J. Smith, a cura di. Conflitto e controllo nella Cina tardo imperiale. Stanford University Press, 1994. – Raccolta di saggi sulla governance, lo stress fiscale e l’instabilità monetaria nella Cina tardo imperiale.
Morgan, KO La pace del popolo: storia britannica 1945–1990. Oxford University Press, 1992. – Fornisce approfondimenti comparativi sulla gestione fiscale del dopoguerra e sulla stabilità economica nel contesto moderno.
Nove, Alec. Una storia economica dell’URSS. Terza edizione, Penguin Books, 1992. – Resoconto completo delle politiche economiche sovietiche, delle crisi valutarie e della cattiva gestione fiscale.
Riasanovsky, NV, e Mark D. Steinberg. Una storia della Russia. 9a edizione, Oxford University Press, 2018. – Copre le strutture politiche, sociali ed economiche del tardo Impero russo, comprese le pressioni monetarie e fiscali.
Rostovtzeff, M. Storia sociale ed economica dell’Impero romano. Oxford University Press, 1957. – Studio classico delle strutture economiche e fiscali nell’antica Roma, utile per il confronto con le economie dinastiche cinesi.
Temin, P. L’economia di mercato romana. Princeton University Press, 2013. – Esplora i sistemi monetari e i meccanismi economici di Roma; offre una prospettiva comparativa sulla stabilità dell’impero.
Tainter, J. Il collasso delle società complesse. Cambridge University Press, 1988. – Analizza il collasso sociale con particolare attenzione alla complessità economica e amministrativa, applicabile alle dinastie cinesi.
Twitchett, D., a cura di The Cambridge History of China. Cambridge University Press, volumi multipli. – Risorsa accademica che descrive in dettaglio la storia politica, fiscale e monetaria da Tang a Qing.
Von Glahn, R. Fontana della fortuna: denaro e politica monetaria in Cina, 1000-1700. University of California Press, 1996. – Studio mirato sui sistemi monetari Song, Yuan e Ming, sulla carta moneta, sui flussi d’argento e sulle crisi fiscali.
von Mises, L. L’azione umana. Yale University Press, 1949. – Opera fondamentale nella teoria economica; fornisce approfondimenti sulla politica monetaria, sull’inflazione e sul processo decisionale in materia fiscale.
