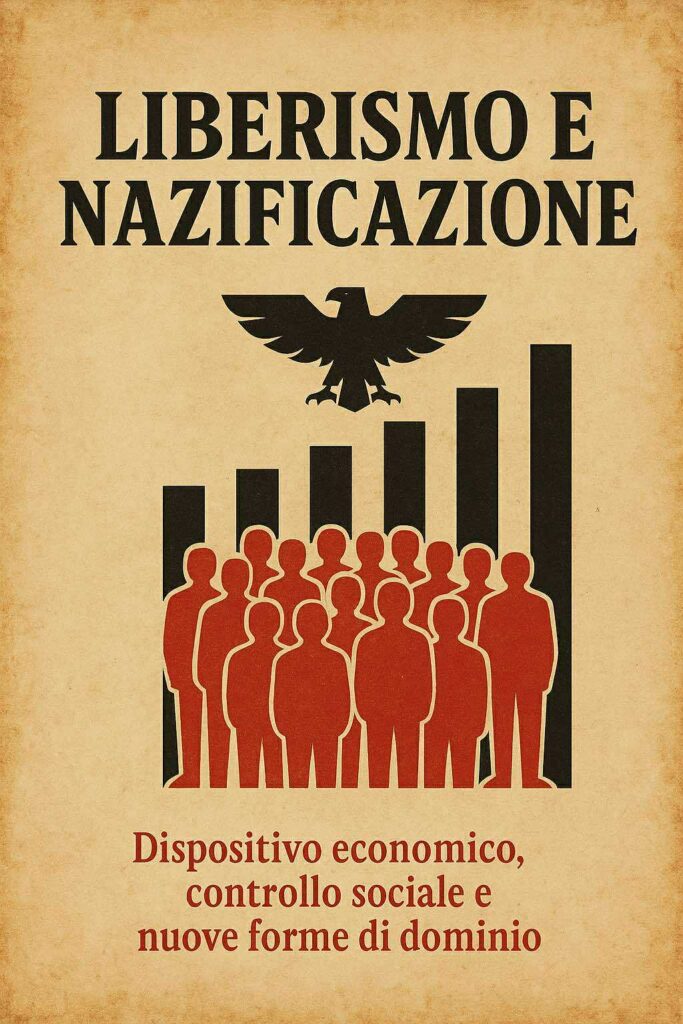
C’è un filo sottile, quasi invisibile, che lega il nostro presente a un passato che credevamo sepolto. Non è la marcia roboante dei regimi del Novecento, non è la voce tonante di un dittatore dal balcone. È piuttosto una trasformazione silenziosa, che procede a piccoli passi, senza dichiararsi, mentre siamo distratti dal frastuono mediatico che ci circonda. Pasolini lo aveva intuito quando denunciava il consumismo come il vero fascismo. Hannah Arendt lo aveva previsto parlando della perdita del mondo comune. David Foster Wallace lo descriveva come “distrazione a tempo pieno”. Tutti, in modi diversi, avevano colto il segno di una metamorfosi: la democrazia che scivola verso una forma di autoritarismo senza simboli, senza divise, ma capace di controllare le coscienze.
Questa metamorfosi è ciò che il saggio definisce provocatoriamente “nazificazione soft”. Non più parate, stendardi, repressione diretta. Ma un lento svuotamento delle istituzioni, una riduzione progressiva dell’empatia, la trasformazione dei cittadini in utenti, delle relazioni in interazioni, dei bisogni in dati da elaborare. La politica diventa management, la società una piattaforma. La comunità si dissolve in un arcipelago di solitudini connesse, ciascuna immersa nel proprio flusso digitale.
La forza di questo processo sta proprio nella sua apparente normalità. Tutto continua a funzionare: i parlamenti si riuniscono, le elezioni si celebrano, i contratti si firmano. Ma dietro le forme sopravvive solo un guscio vuoto. La sostanza – fiducia, legame sociale, responsabilità collettiva – evapora. E ciò che rimane è un simulacro di democrazia, un potere che indossa la maschera del consenso per legittimare logiche di dominio.
Il punto centrale è il ruolo delle élite politiche ed economiche, che si collocano oggi in una posizione di extraterritorialità. Parlano un linguaggio tecnico, inaccessibile alla maggior parte dei cittadini. Decidono in spazi chiusi – Consigli europei, vertici finanziari, riunioni a porte chiuse – lontani dalla vita quotidiana delle persone. E quando queste decisioni arrivano al pubblico, sono presentate come inevitabili: “non ci sono alternative”, “bisogna essere realistici”. Così, l’erosione della partecipazione non appare come scelta politica, ma come fatalità tecnica.
La retorica della necessità sostituisce la deliberazione democratica. È qui che la “nazificazione soft” mostra il suo volto: non un’ideologia monolitica, ma un linguaggio che cancella la possibilità stessa di discutere. Un linguaggio che, come aveva avvertito Arendt, riduce la politica ad amministrazione e i cittadini a spettatori.
Dentro questa cornice si muovono due narrazioni speculari: la cultura woke e il trumpismo. A prima vista sembrano nemici giurati. La prima rivendica inclusione, la seconda difende identità nazionaliste. Ma entrambe finiscono per alimentare lo stesso meccanismo: la frammentazione sociale. La cultura woke, nel suo eccesso di micro-rivendicazioni, dissolve l’idea di un bene comune; il trumpismo, nell’ossessione per il nemico interno ed esterno, trasforma la politica in guerra permanente. Due facce della stessa medaglia: l’incapacità di costruire comunità.
In questa polarizzazione, i problemi reali – disuguaglianze economiche, precarietà del lavoro, crisi climatica – scompaiono dal radar. Il dibattito pubblico si riduce a una lotta di narrazioni, a un teatro di identità contrapposte, mentre le élite restano al di sopra del conflitto, gestendolo e traendone profitto. Pasolini avrebbe denunciato questa messa in scena come il trionfo dell’omologazione culturale. Wallace avrebbe parlato di saturazione mediatica, di un flusso ininterrotto di stimoli che anestetizza ogni pensiero critico.
Un passaggio cruciale del saggio è la trasformazione della classe media. Un tempo pilastro della stabilità democratica, oggi appare intrappolata. Non più forza moderatrice tra capitale e lavoro, ma segmento alienato. Marx descriveva l’alienazione come separazione del lavoratore dal frutto del suo lavoro. Oggi siamo di fronte a una condizione più radicale: il cittadino è alienato come produttore, come consumatore e persino come dato.
È il cuore del “capitalismo della sorveglianza” descritto da Shoshana Zuboff. Le piattaforme digitali non vendono solo servizi: estraggono attenzione, relazioni, desideri. Ogni clic è una materia prima, ogni interazione una risorsa da monetizzare. La classe media, che un tempo aveva margini di autonomia, si ritrova catturata in un flusso continuo di consumo e sorveglianza. La libertà è ridotta a scegliere tra merci equivalenti, la responsabilità individuale sostituisce la solidarietà. Se non riesci, è colpa tua. Se resti indietro, non ti sei aggiornato abbastanza. È una nuova forma di alienazione totale, in cui la colpa sostituisce la coscienza di classe.
Il tema dell’emancipazione femminile introduce un’altra frattura. Il Novecento aveva visto conquiste straordinarie: accesso al lavoro, all’istruzione, all’autonomia economica. Ma dentro la cornice neoliberale, queste conquiste sono state piegate. Il lavoro femminile è stato integrato non per liberare, ma per alimentare produttività e consumo. La maternità è diventata ostacolo, narrata come scelta personale ma spesso imposta da condizioni strutturali.
Silvia Federici ha mostrato come la riproduzione sociale – cura, maternità, legami – sia stata sistematicamente invisibilizzata perché non monetizzabile. Arendt ricordava che la natalità è condizione della politica stessa: ogni nascita è un nuovo inizio. Ridurre la maternità a variabile economica significa amputare la capacità di rigenerare comunità. Eppure, oggi, un numero crescente di donne rivendica la maternità come atto di resistenza, come gesto politico contro un mercato che le vorrebbe solo performanti. In questa tensione si gioca uno dei fronti più delicati della crisi democratica.
Il potere democratico mascherato si manifesta anche nella fiducia evaporata. Serge Latouch osserva che un tempo bastava una stretta di mano per sancire un accordo. Oggi, persino i contratti firmati non hanno più valore. La parola data è priva di peso. La fiducia, che è il cemento di ogni patto sociale, viene sostituita da calcoli opportunistici. Senza fiducia, la democrazia diventa una scenografia pronta a crollare.
Le guerre di procura, i conflitti economici tra alleati, l’uso sistematico della paura come strumento politico: tutto concorre a mantenere il guscio, svuotandolo della sostanza. L’empatia si sposta verso l’“altro lontano”, oggetto di narrazioni globali, mentre l’“altro qui ed ora” – il vicino, il lavoratore precario, l’immigrato reale – viene ignorato. In questa perdita di empatia, Arendt vedeva l’anticamera del totalitarismo. E non serve il manganello per arrivarci: basta la normalizzazione dell’indifferenza.
Siamo al tramonto dell’occidente. Una civiltà che continua a celebrare i riti democratici, ma che ha già perso l’anima. Una società in cui il cittadino non riconosce più sé stesso nella comunità politica. In questo vuoto, il rischio è che germoglino nuove forme di dominio, più sottili ma non meno pervasive.
La vera sfida, scrive l’autore, non è difendere la democrazia da minacce esterne, ma ricostruirne le basi interne: fiducia, cura, empatia, comunità. Restituire valore alla parola data. Ridare spazio alla natalità come inizio, non come statistica. Riconoscere che senza un legame reale, nessun sistema resiste.
Se questo sforzo non verrà intrapreso, la maschera cadrà. E il volto che apparirà non sarà quello di una democrazia rinnovata, ma quello di una civiltà che ha smesso di credere in sé stessa. Un Occidente che, dopo aver colonizzato il mondo, non riesce più a colonizzare la propria disperazione
